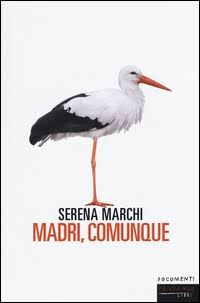20 settembre 2020
(articolo già pubblicato su http://www.barbararomagnoli.info)
In ricordo di Rossana Rossanda, ripubblico qui di seguito un testo contenuto nel volume “Scritture di Frontiera – Tra giornalismo e letteratura” a cura di Clotilde Barbarulli, Liana Borghi e Annarita Taronna, 2007, edito da Università degli Studi di Bari in collaborazione con Sil Società italiana delle letterate.
In questo lavoro ho inteso tracciare gli aspetti più importanti della figura di Rossana Rossanda con un breve accenno a «Il Manifesto», giornale quotidiano di cui lei è stata cofondatrice. Del lavoro di Rossanda ho messo in risalto un aspetto particolare, ossia il suo essere giornalista ‘militante’, dove per giornalismo ‘militante’ o ‘impegnato’ ? che è per definizione una scrittura di frontiera ? si intende l’uso della scrittura come scelta politica e strumento per trasformare il mondo.
Ho evidenziato questo aspetto anche per tentare di ragionare attorno ad un fenomeno che è sempre più presente in Italia nel campo della comunicazione e che veicola lo stereotipo della ‘donna-velina’. Ritengo, infatti, che il cliché della donna-velina non solo veicoli uno specifico sguardo sul corpo femminile, ma sia anche metafora di una maniera di intendere l’informazione, in particolar modo nei media mainstream che preferiscono la spettacolarizzazione della notizia a scapito dell’approfondimento, della ricerca e dell’esercizio della critica da parte di chi svolge questa professione. Mi sembra che il giornalismo praticato da Rossanda possa essere preso come modello ? o almeno come spunto per una critica costruttiva ? in contrapposizione al cliché della donna-velina imperante nell’attuale panorama mediatico e culturale italiano.
Comincio dal principio, chi è Rossana Rossanda. Non è un mito, né vuole esserlo, come lei stessa precisa all’inizio della sua autobiografia, ma credo possiamo tutti concordare nel considerarla una delle più grandi intellettuali e saggiste italiane del XX secolo. Rossanda nasce a Pola, città di frontiera, nel 1924 e la sua famiglia di estrazione medio-borghese venne travolta dalla crisi del ’29. Quindi, si trasferì prima a Venezia e poi a Milano, dove all’università fu allieva del filosofo Antonio Banfi ma, soprattutto, dove la sua vita fu radicalmente cambiata dallo scoppio della seconda guerra mondiale. È la guerra che le fa scoprire la politica fino a quel momento tenuta distante dal suo ambiente familiare che era tuttavia intellettuale, come ricorda Rossanda nella sua autobiografia: poca politica ma molti libri.
A chi le domanda perché, vista la sua origine familiare, è diventata comunista e non antifascista liberale, risponde:
Volevo fare un’altra vita, ma la guerra che cadde come qualcosa di mostruoso e imposto, mi fece pensare che dobbiamo cambiare il meccanismo di funzionamento del mondo. La libertà ha delle condizioni necessarie. Dal ’39 al ’46 avevamo solo la libertà di essere vivi. E neanche quella. La scelta di campo nasce dall’evidenza che troppa gente viene al mondo e non può essere padrona della propria esistenza. Non lo accetto e il comunismo è questo: la possibilità di prendere in mano la propria vita, è intollerabile che ci sia chi non lo possa fare.
Decide così, giovanissima, di partecipare alla Resistenza partigiana e, al termine della seconda guerra mondiale, si iscrive al Partito Comunista Italiano. In breve tempo, viene nominata da Palmiro Togliatti responsabile della politica culturale del Pci e viene eletta nel 1963 alla Camera dei Deputati.
Arriva il 1968, un anno di svolta anche nella biografia lavorativa di Rossanda. La giornalista pubblicò un piccolo saggio intitolato L’anno degli studenti, in cui affermava la sua adesione al movimento della contestazione giovanile che era deflagrata in tutto il mondo. Con un percorso di riflessione condiviso con altri, Rossanda in quegli anni si dichiara anche contraria al socialismo reale dell’Unione Sovietica. Nasce l’idea di una rivista di critica e riflessione e viene così fondato «Il Manifesto», esperienza che fu sia una rivista mensile e un giornale quotidiano, sia un partito. Anche per questo motivo, poco dopo Rossanda fu radiata dal partito, insieme ad altre e altri.
Questi brevi accenni alla sua biografia sono già sufficienti a cogliere la peculiarità del suo sguardo sul mondo e l’influenza che questo ha avuto sul suo lavoro giornalistico. Ma ci dicono anche che per Rossanda la politica è stata l’essenza di una vita e nel suo essere donna non si è mai occupata di questioni specificatamente femminili, tutt’altro. Quando lo ha fatto, ha sempre tenuto presente l’orizzonte complessivo nel quale anche le tematiche più vicine al movimento delle donne si inscrivono. Rossanda non scrive unicamente per se stessa ma per cercare «di capire e di informare su quel che avviene nel mondo attraverso una griglia di interpretazione di sinistra, comunista, libertaria, laica». Come lei stessa afferma: «Poiché nessuno di questi termini è di moda, il mio giornalismo è senz’altro militante». Per giornalismo militante intendo qui riferirmi a chi, come Rossanda, svolge questo mestiere con un approccio che unisce il rigore e il rispetto della tecnica giornalistica (ossia attenersi, pur nella discrezionalità di chi scrive, alla ricerca della verità dei fatti) alla passione civile che utilizza lo strumento giornalistico per modificare/trasformare il mondo e la politica che lo gestisce (che non significa alterare o limitarne l’immagine, ma restituire al lettore la pluralità e la conflittualità che il mondo contiene).
È questo che Rossanda ha fatto in trentacinque anni e più di lavoro, anche considerando come lei stessa dice che
c’è sempre un rapporto tra politica e giornalismo. In generale il giornalista risponde, in modo più o meno mediato, all’idea di società difesa dalla sua testata, che in genere è anche quella di una grande proprietà. Non esiste un giornalismo ‘oggettivo’. Che vorrebbe dire? C’è la selezione delle notizie a monte, a cominciare dalle agenzie, sennò neppure sarebbero discernibili; ma non è innocente. La selezione è retta da un criterio che è poi un giudizio. Secondo me [aggiunge Rossanda] la cosa più onesta è far cosciente il lettore di questa scelta e del punto di vista dal quale si scrive, giudizi e pregiudizi inclusi.
È proprio con questa filosofia che Rossanda (insieme a Luigi Pintor, Lucio Magri, Valentino Parlato, Luciana Castellina e altre e altri) decide di dar vita ad un progetto editoriale indipendente, un giornale che vuole essere «provocatoriamente solo politico, e per politica si intendeva in senso stretto il movimento anzi i grandi movimenti della storia». La novità de «Il Manifesto» è il non essere legato a nessuna proprietà specifica che possa influenzarne la politica editoriale. È gestito da un collettivo di giornalisti e si è costituito in cooperativa, cosicché si trova a non avere una proprietà davvero distinta dalla redazione, con giornalisti che sono editori di se stessi.
«Il Manifesto» è nato come voce comunista fuori dal partito, indubbiamente un’esperienza insolita, e nel corso degli anni, tra le varie cose, si è sempre schierato contro ogni guerra come modello militare di gestione dei conflitti. Il giornale ha scelto, infatti, sempre di parlare anche delle tante guerre dimenticate e lo ha fatto in maniera non embedded, termine entrato di recente nel nostro vocabolario. Con embedded si faceva riferimento agli inviati speciali nella guerra del Golfo, poi è diventato un modo per definire chi svolge questa professione attenendosi a “ciò che si vuole venga detto”. Per dirla con le parole di Rossanda:
Perlopiù il giornalista è embedded al sistema dominante. Il ‘dominio’ non è fatto solo di comandi o quattrini, possibilità o no di essere assunti, ma di molte sottili seduzioni: ci sarà una ragione se questo piace o interessa, se questo attira il lettore e quest’altro no, se il gossip fa pubblico, se si dà fastidio ricordando di continuo i mali e le sofferenze del mondo ecc. La spirale di connivenza tra quel che il giornalismo dà, il pubblico ama ricevere e il sistema dominante è molto stretta. In questi anni è passata la tesi che il liberismo [non il liberalismo] è il meno peggio, che ogni tentativo di mutamento sarà disastroso o sconfitto, che l’equilibrio è garantito solo dal mercato. Ne derivano anche una mercificazione e un ‘consumo’ delle idee.
Qui Rossanda ci dice qualcosa di importante anche sulla scelta dei contenuti che spesso sono una discriminante fondamentale per capire la differenza tra giornalismo militante e giornalismo mainstream.
Infatti, il XX secolo ha visto passaggi storici importanti e su questi si è focalizzato il lavoro di Rossanda. Faccio riferimento al fatto che alle due guerre mondiali è seguito un dopoguerra caratterizzato dalla divisione del mondo in due blocchi, la successiva fine della guerra fredda e la disgregazione dell’ex Unione Sovietica, la globalizzazione neoliberista che ha accelerato molti processi di trasformazione, l’avvento di Internet, la “guerra permanente” entrata con la tv nelle case di tutto il mondo, l’antico controllo politico e religioso sul corpo e l’immagine delle donne che ha assunto nuove forme (la guerra in Afghanistan è stata giustificata anche come liberazione delle donne dal velo talebano), fino ad arrivare all’11 settembre e a quello a cui stiamo assistendo oggi. Tutte queste tematiche, da me solamente accennate, sono state il contenuto privilegiato da Rossana Rossanda per i suoi scritti, articoli e saggi, spesso lungimiranti e in alcuni casi ancora molto attuali ? mi riferisco in particolar modo ad esempio alla raccolta di articoli che è stata pubblicata nel volume Note a margine.
Quindi Rossanda viene da questa storia, ne è stata testimone e l’ha poi raccontata, anche se, come lei stessa più volte ricorda, è diventata giornalista non per scelta professionale: «Avrei fatto dell’altro», dice, «ho fatto la giornalista come forma della politica dopo la radiazione dal Pci, il movimento del 1968, e poi la crisi crescente dei partiti…». Non è un caso che Rossanda abbia preso le distanze dalla professione giornalistica intesa come status symbol e che abbia rifiutato di essere iscritta al’Ordine nazionale dei giornalisti, istituzione italiana che non ha simili in Europa e che tutt’ora continua ad essere una organizzazione prettamente gerarchica e maschilista.
Inoltre, è importante ricordare che in Italia il sistema dei mass media non è di fatto pluralista (anche se nell’ultimo decennio sono notevolmente cresciuti i media indipendenti, via Internet, radio e stampa, spesso di carattere militante, che restano però esperienze di nicchia. Per fare un esempio che faccia capire la situazione, «Il Manifesto», indipendente, vende circa 40mila copie al giorno, mentre il «Corriere della Sera» legato a gruppi di potere specifici vende circa 900mila copie). Il sistema informativo italiano è fortemente dominato da lobby e/o interessi politici ? basti solo dire che il premier Berlusconi da solo controlla tre televisioni.
Rossanda nel suo lavoro ha dunque affrontato tutti questi nodi e complessità a cavallo tra due secoli e la particolare situazione italiana. Nel farlo, ha più volte puntato il dito, come dicevamo poco fa, sul mito del mercato e conseguente «mercificazione e “consumo” delle idee», un consumo di idee che ha, tra l’altro, l’obiettivo di veicolare stereotipi e immagini che riguardano la donna, sostenendo il modello di una donna-corpo come merce al pari di tutte le altre.
Secondo Rossanda,
anche a noi donne viene suggerito che, raggiunti alcuni innegabili diritti [votare, possedere o ereditare, non essere obbligate a sposare il tizio o il caio, potersene andare di casa, insomma una certa parità] conviene restare ‘femminili’, seduttive, moderatamente materne, signore del privato [salvo essere fatte fuori dal consorte], fuori dalle responsabilità del pubblico ed efferate consumatrici. Le donne si lasciano limitare con troppa facilità nelle loro ‘effettive capacità’. Finisce che neanche esse le conoscono più, perché poi uno è quel che fa. Il maschilismo resta imperante anche perché non ci sono più grandi battaglie contro di esso: siamo talmente tante donne nei media che, se davvero volessimo, potremmo imporre e imporci. Né si può dire che quelle fra noi che difendono un’altra immagine di sé rischiano la fucilazione. Resta perciò da vedere se il più delle volte non siamo complici della ‘velinità’ cui ci vogliono ridurre.
Rossanda, dunque, provocatoriamente chiede conto, in un certo senso, della “velinità” che c’è in noi e non è certo semplice dare una risposta. Credo sia interessante, per ragionare attorno a questo interrogativo, accennare brevemente alla storia del termine ‘velina’ in Italia, che è prima di tutto un tipo di carta molto sottile e trasparente.
Nella storia del giornalismo italiano si fa riferimento col termine veline ai dispacci del Ministero della Cultura Popolare, tramite i quali il regime fascista diramava agli organi di stampa e di informazione le notizie da rendere note (o meno) all’opinione pubblica. Ancora oggi, si usa “veline” per indicare i comunicati stampa che normalmente arrivano da governo o enti pubblici e che intendono suggerire al giornalista cosa e come scrivere la notizia. Ma è negli anni Ottanta, con la comparsa in Italia della tv commerciale che spunta la figura della donna-velina. La propone il programma televisivo “Striscia la notizia”, una sorta di telegiornale che vorrebbe unire satira, politica e varietà. Gli autori di “Striscia” decidono che le due ragazze “veline” sono le addette alla consegna delle notizie ai presentatori. Sembra che nell’intento degli ideatori ci fosse la volontà esplicita di richiamarsi in chiave polemica al periodo fascista per rivendicare l’inviolabile diritto alla libertà di stampa e di informazione, anche al di fuori dei canali ufficiali. Paradossalmente, dunque, negli anni Ottanta il corpo della donna-velina verrà usato inizialmente proprio come simbolo di una informazione che si definiva libera e indipendente ? un messaggio che credo però sia andato in un’altra direzione, se non addirittura opposta.
Le veline sono comunque sempre donne giovani e avvenenti che devono con la loro presenza e qualche performance richiamare l’attenzione e l’audience del pubblico. In poco tempo, grazie al successo della trasmissione, il termine “veline” è entrato nel modo di pensare comune e in senso lato viene anche utilizzato in modo spregiativo per indicare le giovani ragazze che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo senza necessità di percorsi formativi o una graduale esperienza. La velina è diventata la pretesa di essere famosa senza saper fare nulla. Una sorta di rimedio universale alla disoccupazione. Attorno a questo ragionamento torna utile e anche suggestiva la provocazione di un gruppo femminista romano A/matrix che, riflettendo su questi temi, afferma: “Un mondo diverso è un mondo in cui anche la velina che è penetrata in ognuno di noi, donna e uomo, decide di scioperare. Siamo tutte e tutti veline. La velina è il paradigma della nostra dignità sociale perché nella società mercantile imperante è l’icona della conformità soggettiva ed esistenziale. La velina è il mordi e fuggi, l’usa e getta, il produci e consuma. Se l’immagine quotidiana venisse privata del nostro contributo, se le veline interrompessero i luccicanti sogni che i loro corpi e sorrisi promettono, se la velina si considerasse soggetto desiderante, saremmo già in un altro mondo”.
Credo che in questa imperante mercificazione del corpo femminile sia sempre più attuale il dibattito, iniziato con il femminismo degli anni Settanta e non ancora concluso, sul conflitto/confronto tra libertà-mercato-autodeterminazione della donna. Con l’evidente vittoria della mera emancipazione sulla liberazione e consapevolezza della donna.
Quindi, nonostante sia chiaro a quale stereotipo di donna rimanda il cliché della donna-velina, i media fomentano questo senso comune ed alimentano la “velinità” di cui parla Rossanda. Non c’è dubbio che sia maggiormente l’informazione mainstream rispetto a quella di carattere militante a scegliere una immagine di donna, e non solo, che preferisce l’apparire all’essere e che soprattutto, volendo utilizzare i termini di un vecchio dibattito femminista ancora aperto, attraverso il consolidamento di certi stereotipi, i media mainstream facilitano il lavoro di chi vuole il controllo sui corpi e sulle menti delle persone, in particolare sulle donne.
Appare invece evidente, rileggendone la vita e gli scritti, che Rossanda non si è mai piegata al modello del mondo maschile, lo ha certamente frequentato e ne ha preso parte attivamente, ma sempre nell’ottica di una modifica e di un miglioramento della società per tutte e tutti. Da un lato, quindi, abbiamo un modello di giornalista impegnata che non ha mai esitato a prendere parola sulle questioni del mondo e non ha mai perso la sua autonomia, dall’altro la donna-velina che pensa, mostrando il corpo, di essere libera e indipendente e che invece diventa simbolo di una informazione preconfezionata e funzionale ad un certo sistema. La questione è complessa e non certamente riducibile soltanto alle dinamiche interne alla società della informazione e comunicazione che, come ben sappiamo, riflette tutti gli aspetti di una società. Da tutto quello detto fin qui, la velina appare quanto più lontano possa essere dalla immagine di donna-giornalista che potrebbe invece rappresentare Rossanda la quale, tra l’altro, non può essere certamente classificata come femminista in senso stretto.
Non abbiamo in questa sede il tempo per approfondire il complesso rapporto avuto da Rossanda con il femminismo, ma con esso Rossanda ha intessuto negli anni un dialogo critico e fecondo, come lei stessa ricorda anche nella introduzione al volume Le altre, dove racconta l’esperienza radiofonica a fine anni Settanta, quando in una serie di conversazioni a Radiotre la giornalista si confrontò su alcune grandi parole-valori della politica (libertà, fraternità, eguaglianza, democrazia, resistenza, solo per citarne alcune) con donne che invece vissero in prima persona l’esperienza del femminismo degli anni Settanta (tra queste Lidia Campagnano, Letizia Paolozzi, Manuela Fraire).
In conclusione, vorrei ricordare proprio uno dei dubbi sollevati da Rossanda alle sue amiche e donne femministe. A queste donne che tanto si sono battute perché mutassero linguaggi e forme della rappresentazione della donna anche nei media, Rossanda ha più volte chiesto «cosa ha impedito al movimento delle donne di diventare intanto una forza capace anche di durare, di garantirsi uno spazio […] e soprattutto di generalizzare la propria cultura, farla passare…». Ossia, cosa impedisce ancora oggi alle donne di trasformare una cultura che le rappresenta in chiave sessista e discriminante.
A suo tempo, Rossanda disse che la grande forza del femminismo era stata l’aver portato allo scoperto e al centro della politica il corpo, la sessualità, l’esperienza dell’individuo in un’ottica di consapevolezza e riappropriazione della parola su se stessi. Il limite era stato quello di non riuscire a estendere questo modello fuori dal piccolo gruppo e delegare ad altri, spesso uomini, la lotta contro i “poteri reali”, gli stessi che cercano di dominare anche l’informazione e i media. Forse è da questo interrogativo che è necessario ripartire affinché anche nei media la donna possa essere se stessa senza omologarsi al modello maschile dell’usa e getta e con il riconoscimento delle sue capacità e responsabilità al pari di un qualsivoglia collega maschio.
Nota: le citazioni in corsivo sono frutto di una intervista a Rossanda a cura dell’autrice.